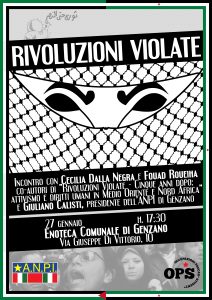Da CommuniaNet
Da CommuniaNet
Pubblichiamo questo intervento di Pierre Rousset come contributo alla discussione aperta sui temi dell’imperialismo e della solidarietà internazionalista. Il testo fa molti riferimenti alla storia e alla realtà del movimento di solidarietà internazionale francese, ma pensiamo sia comunque utile a riallacciare le fila di un ragionamento sul tipo di solidarietà nei confronti delle esperienze di autodeterminazione e/o liberazione, in questo caso con un occhio particolare a quelle armate.
Una discussione utile anche in Italia, dove la solidarietà internazionale risulta spesso piuttosto “strabica” – come si vede nel caso del sacrosanto sostegno alla resistenza delle/dei kurde/i a Kobane (o dei palestinesi di Gaza) e ila contestuale “distrazione” riguardo i massacri del regime siriano, o verso le rivolte della regione araba dal 2011 ad oggi. (redaz. internaz.)
Chiaramente la solidarietà non è soltanto la denuncia del proprio imperialismo: deve anche rispondere alle necessità concrete (politiche, umanitarie e materiali) dei popoli e dei movimenti di cui sosteniamo la lotta. Ciò a volte non crea dei problemi particolari, come quando difendiamo gli attivisti condannati a pene ingiuste da tribunali speciali; in molti altri casi per essere efficaci dobbiamo imparare dalle condizioni in cui queste lotte vengono portate avanti, e non c’è nulla di scontato in tutto ciò.
L’internazionalismo ha una sua storia: le sue modalità sono influenzate in modo particolare dalla globalizzazione capitalista, dal carattere, ora globale, della crisi ecologica, dal subbuglio geopolitico in corso, dalla crisi del movimento operaio e dalla perdita di legittimità dei riferimenti socialisti. Tutte le aree di solidarietà sono colpite da questi mutamenti radicali; su questo tema è stato scritto molto e non ci ritornerò. Mi piacerebbe concentrarmi su domande specifiche sorte dal sostegno alla resistenza e alle lotte armate popolari.
Ciò ovviamente non significa mettersi le vesti dell’esperto militare bensì acquisire un minimo di “intelligenza politica” in questo campo di lotta. Negli anni ’60 e ’70 abbiamo lavorato sulla questione della guerra rivoluzionaria, la guerra protratta del popolo e la guerriglia urbana cercando di assimilare le lezioni delle lotte armate di quegli anni e le linee guida attuate dalle principali organizzazioni (elenchiamo alcuni degli autori più noti sul tema: Trotsky, Mao, Giap, il Che, i Tupamaros e così via).
Non sto cercando di fare un bilancio di quegli “anni di fuoco” bensì di paragonare il passato al presente per quanto riguarda il ruolo della solidarietà, soprattutto tenendo conto dei mutamenti radicali del quadro geopolitico. Faccio riferimento principalmente alle esperienze asiatiche visto che sono stato coinvolto nelle mobilitazioni sul Vietnam prima del ’68 e poi nella fondazione (nel ’69) e nella guida del Fronte di Solidarietà con l’Indocina, per poi essere attivo in numerose organizzazioni di solidarietà con paesi come la Thailandia o le Filippine.
I movimenti armati della sinistra e/o dei popoli oppressi non sono mai scomparsi dalle mappe dell’Asia (India, Filippine, Birmania, Thailandia meridionale, Nepal, Sri Lanka e così via) anche se nella maggior parte dei casi il dinamismo sociopolitico iniziale delle lotte armate “persistenti” si è esaurito ed alcuni di questi movimenti hanno deposto le armi o si sono posti in una posizione precisamente difensiva (l’autodifesa) – ed alcune altre sono degenerate. Ricordiamo che la rivoluzione nepalese (la conquista temporanea del governo da parte di un’organizzazione armata “classica” tramite l’azione di massa ed il processo elettorale) è un fatto recente datato 2006. Ma nella maggior parte delle regioni del mondo le lotte armate sono cessate (a parte alcune eccezioni come la Colombia) o sono state rimpiazzate dalla militarizzazione e l’etnicizzazione dei conflitti (tema che non tratteremo). Inoltre la fine degli “anni di fuoco” a volte è stata traumatica (anche per noi, nello specifico con lo schiacciamento militare della nostra piccola organizzazione Argentina e del PRT).
Fateci dire che gran parte della sinistra radicale internazionale ha smesso di riflettere sulle condizioni della lotta armata o della resistenza così non abbiamo esaminato da questo punto di vista le nuove esperienze, in particolare nel mondo arabo dopo il 2011, e le discussioni sui compiti della solidarietà.
L’acquisizione delle armi: ieri e oggi
La questione del disarmo della borghesia è ovviamente un punto cruciale per un punto di vista rivoluzionario ed ha come regola generale il corollario del dare le armi al popolo.
In alcuni casi le forze rivoluzionarie hanno sin dall’inizio le armi ed una conoscenza militare significativa: in Russia (1917) con la decomposizione dell’esercito zarista sconfitto sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale; in Cina (1927) con la rivolta di parti dell’esercito nazionale che si sono uniti alle insurrezioni popolari ed hanno contribuito alla fondazione dell’Armata Rossa. In molti altri casi è stato diverso: le armi e l’esperienza venivano acquisite in modo graduale nel corso di un processo generale di “accumulazione di forze” (tra cui il radicamento sociale e l’espansione geografica).
Al di fuori dell’unione delle forze armate esistenti alla rivoluzione ci sono grosso modo quattro modi per ottenere le armi:
– Prenderle dal nemico durante le operazioni militari (od anche acquistarle dai soldati o dagli ufficiali dell’esercito governativo).
– Produrle in fabbriche clandestine se possibile in zone protette dall’intervento nemico.
Questi primi due punti formano la base del processo di armamento di una lotta armata popolare “classica”. Sono fonti indipendenti, di “autoarmamento”, collegate al rafforzamento del radicamento sociale e all’estensione geografica del movimento – tutti elementi molto importanti visto che la capacità politico-militare di un’organizzazione rivoluzionaria non dipende soprattutto dalla sua potenza di fuoco bensì dalle sue radici.
Comunque questo tipo di processo è necessariamente e relativamente lento e raramente permette di ottenere un gran numero di armi. Perciò si può far ricorso a:
– Il contrabbando, molto costoso e non privo di pericoli visto che mette l’organizzazione a contatto con dei circoli dove operano gli agenti di numerosi servizi segreti;
– Governi più o meno “amici”, che spesso hanno i loro obiettivi e che utilizzano gli aiuti come un mezzo per far pressione. All’epoca erano la Russia, la Cina, la Corea del Nord, la Libia e Cuba.
Per fare ciò i movimenti che guidavano delle lotte armate progressiste hanno raramente fatto un appello pubblico alla solidarietà internazionale. Di solito i contatti con i governi erano discreti e le campagne di solidarietà materiale riguardavano prevalentemente l’aiuto finanziario (che i movimenti potevano utilizzare a piacimento) o l’aiuto sanitario (spedizioni di equipaggiamento medico, viaggi di dottori nelle zone di guerriglia e così via). Poiché parlavamo proprio della questione delle armi ecco due esempi:
– Durante la guerra algerina di liberazione i membri della Quarta Internazionale hanno creato una fabbrica clandestina per la produzione di armi (mortai, granate, fucili e così via) per l’FLN. C’erano operai specializzati selezionati per le loro abilità da diversi paesi.
– Con l’escalation militare statunitnese in Indocina chiedemmo a Mosca di fornire ad Hanoi dei missili che permettessero la protezione dei cieli del Vietnam del Nord – soprattutto dai micidiali bombardieri B52. Queste armi di alto livello non sono mai arrivate ma il Partito Comunista Vietnamita fu in gradi di organizzare una difesa contraerea adattando i principi della guerra del popolo (Giap) e facendo un miglior uso delle armi fornite dall’Unione Sovietica o dalla Cina.
Bisogna notare che guardavamo a Mosca non perché lo considerassimo un regime “rivoluzionario”. Lo consideravamo come controrivoluzionario a livello interno (la controrivoluzione burocratica) e per gran parte della sua politica internazionale (all’epoca della “coesistenza pacifica”). Ma da un punto di vista geopolitico convivevano due linee di conflitto: tra la rivoluzione e la controrivoluzione, con il Vietnam come punto cruciale, e tra il “blocco orientale e quello occidentale” (a cui si era aggiunto il conflitto interburocratico Cino-Sovietico).
Nel 1954 Mosca e Pechino diedero un duro colpo alla lotta di liberazione dei vietnamiti quando costrinsero il PCV ad accettare gli accordi di Ginevra che portavano in sè il germe di una nuova guerra – la più mortale e totale delle guerra – questa volta guidata direttamente da Washington.
Comunque possiamo affermare che Mosca e Pechino hanno sia aiutato che tradito la rivoluzione vietnamita – e noi, con il movimento di solidarietà, per quanto ne eravamo in grado abbiamo sfruttato questa relazione contraddittoria.
La geopolitica odierna è molto diversa: Russia e Cina sono potenze capitaliste. Mosca sostiene militarmente regimi come quello di Assad e sarebbe assurdo chiedergli di fornire armi alla ribellione popolare siriana (come sarebbe stato assurdo chiedere a Parigi o a Washington di aiutare i rivoluzionari vietnamiti!). Ciò significa che i popoli che resistono e che praticano la lotta armata (e quindi i movimenti di solidarietà) non possono più sfruttare qualsiasi contraddizione tra le potenze?
Oggi inoltre nel teatro siro-iracheno intervengono numerosi attori esterni, a volte pesantemente armati, con movimenti fondamentalisti sostenuti dall’Iran, l’Arabia Saudita, il Qatar ed altri in una geopolitca regionale che spinge verso la distruttiva confessionalizzazione dei conflitti. È una situazione alquanto singolare, quali potrebbero essere le implicazioni sulla questione delle armi?
Per rispondere a queste due domande mi sembra necessario ritornare alle battaglie di Kobane e di Aleppo, per quanto possa capire poco di quanto sta avvenendo in un paese dove non ho contatti diretti.
Kobane
La battaglia di Kobane è decisiva? In molti casi la perdita di un centro urbano può costare caro ma senza serie conseguenze per il proseguimento di una guerra rivoluzionaria. Un esempio classico: durante il conflitto sino-giapponese le forze controrivoluzionarie di Chiang Kai-Shek presero Yan’an, la “capitale rossa” del Partito Comunista. Il simbolo era forte ma questo fatto condizionò la lotta solo a livello locale: l’Armata Rossa riposizionò gran parte delle proprie unità nel nordest del paese, dietro il fronte giapponese ed al riparo dalle armate bianche di Chiang, dove il PCC aveva creato delle aree liberate che avevano un’importanza strategica molto superiore della “base” iniziale a Yan’an.
Ciò non è vero per Kobane: oltre al simbolo, esso stesso molto forte, la posta in gioco in questa battaglia è molto alta dal punto di vista del Kurdistan siriano. In un piccolo territorio posto su un confine ostile (quello turco) le forze kurde non hanno lo spazio per schierarsi altrove mentre lo Stato Islamico sta massacrando e deportando la gente (comprese le donne destinate alle unità di combattimento) inducendo ad un esodo di massa. In queste condizioni la perdita di Kobane mette a repentaglio tutto il Kurdistan siriano e le trasformazioni sociali in corso.
Allora la battaglia di Kobane deve essere vinta mentre lo Stato Islamico ha mobilitato un’ingente quantità di risorse per conquistarla perché anche dal loro punto di vista la posta è alta: la conquista di questa città gli permetterebbe il controllo continuativo di una gran parte del confine turco.
Dato il rapporto tra le forze militari i curdi possono vincere solo con tre condizioni:
– Una grande capacità di resistenza delle forze del PYD a Kobane, senza la quale nulla è possibile.
– Forniture di armi per attaccare i veicoli blindanti dello Stato Islamico.
– Il bombardamento delle colonne militari dell’IS per impedirgli di raggiungere la città, di operarvi liberamente o di portare delle truppe di rinforzo.
Non sto dettando alcuna “linea”, è solo un’osservazione dei fatti – giusta o sbagliata – che non dipende in alcun modo da un “punto di vista” politico. Comunque è un’osservazione di cui dobbiamo tener conto se non vogliamo negare la realtà.
Seconda osservazione: la resistenza curda è riuscita a costringere Washington a cambiare la sua politica sul Kurdistan siriano: gli Stati Uniti non volevano intervenire a Kobane così come avevano fatto intorno alla diga di Mosul (nel Kurdistan iraqeno): c’era il veto turco, l’importanza strategica marginale (ai loro occhi) rispetto allo scenario generale delle operazioni, la priorità data all’Iraq, il rifiuto di riconoscere le forze curde legate al PKK (definito “terrorista”) e così via.
Per questi motivi il comando statunitense non ha colpito le colonne di blindati e l’artiglieria dello Stato Islamico prima che raggiungessero Kobane (mentre la situazione sul campo avrebbe permesse un bombardamento molto efficace) ed i rifornimenti sono arrivati tardi.
Ciò che ha forzato la mano di Washington, oltre all’accanita resistenza dei curdi e del PYD, è stata la copertura su scala mondiale: l’assalto guidato dall’IS, la resistenza curda, l’inattività della Coalizione, le manovre della Turchia di Erdogan, tutto è stato filmato dal confine e trasmesso in televisione. L’abisso tra le pretese umanitarie dell’intervento imperialista e la realtà delle sue azioni (o della sua inattività) è divenuto palese ed insostenibile.
Le guerre imperialiste
È tanto più possibile pesare sulle contraddizioni dell’intervento imperialista in Iraq e Siria, in quanto è stato deciso con urgenza, senza alcun piano strategico, per rispondere a una situazione che era improvvisamente andata fuori controllo. Ciò è molto diverso dalle condizioni delle guerre in Afghanistan (2001) o in Iraq (2003) – o dall’intervento francese in Mali (gennaio 2013).
In quest’ultimo caso Parigi aveva pianificato l’intervento con il rilevante obiettivo (inizialmente nascosto) di inviare delle truppe di terra nell’ottica di un riposizionamento del proprio apparato militare nella regione. Se il governo francese stava reagendo ad una crisi reale del regime maliano ha anche amplificato la forza delle organizzazioni fondamentaliste per giustificare la propria decisione: anche con il sostegno (temporaneo) dei tuareg i “jihadisti” arabi provenienti dal nord e dall’estero non avrebbero preso il controllo di Bamako e del sud del paese.
Non si può dire che la presidenza statunitense abbia ingigantito l’ascesa dello Stato Islamico (al contrario l’ha a lungo sottostimata). Ha agito sotto la pressione degli eventi e senza degli obiettivi di guerra chiaramente definiti, a parte alcuni punti ovvi (bloccare i progressi dell’IS, stabilizzare il regime di Baghdad e così via). Desidera evitare di impantanarsi nuovamente in una “palude” mortale inviando le proprie truppe sul campo (a parte i consiglieri militari).
Ciò nonostante c’è bisogno di truppe sul campo, ma quali? L’esercito iraqeno è impotente, le forze curde del PKK sono efficaci ma politicamente avversate, le forze iraniane in Iraq non sono (ancora) degli alleati affidabili e le componenti non fondamentaliste della resistenza siriana sono state abbandonate da molto tempo al loro destino ed hanno perso molto terreno. Il numero dei consiglieri militari ha già raggiunto le 3000 unità e Washington potrebbe aver deciso di fare un passo più lungo di quanto avesse desiderato.
Come altra fonte di contraddizioni Washington ha deciso di costruire un’ampia coalizione di stati con alcuni interessi confliggenti: dalla Turchia (la principale potenza NATO nella regione) all’Arabia Saudita, che difficilmente può passare come un difensore dei diritti delle donne e della democrazia.
Quindi non siamo nel 2003, le guerre imperialiste che si sono succedute si mettono insieme ma non si assomigliano completamente. Oltre agli elementi costanti che dobbiamo sempre denunciare dobbiamo anche comprendere le loro specificità e le loro contraddizioni intrinseche, il chè non è sempre semplice ma ci permette una valutazione migliore delle condizioni in cui si stanno svolgendo le lotte e di come la solidarietà possa essere efficace.
Pertanto una delle caratteristiche speciali del conflitto in corso è che nello stesso teatro globale delle operazioni siro-iraqene ci sono tante guerre diverse che si mescolano e si intrecciano. Sul piano strategico i destini di tutti i popoli coinvolti sono legati tra loro ed è necessaria l’unione delle forze progressiste. Nello specifico i dettagli concreti delle tattiche relative al combattimento possono variare di molto e in certi periodi possono anche “divergere”. Quì tratto solo di Kobane ed Aleppo ma nel complesso i conflitti evolvono anche secondo situazioni molto specifiche o allineamenti globali e alleanze locali, che fluttuano e si confondono [1].
Aleppo
Mi piacerebbe fare tre esempi sulla differenza tra la situazione a Kobane e quella della resistenza popolare in Siria, personificata dalla battaglia di Aleppo. Tre esempi che hanno delle implicazioni per la solidarietà.
Visibilità. La resistenza popolare ad Aleppo non ha beneficiato della stessa copertura mediatica di Kobane, anche solo per ragioni topografiche: non può essere filmata dal “balcone” turco. Inoltre non beneficia della rete di associazioni e movimenti in Europa e in altri luoghi della stessa grandezza di quella della sinistra curda (e del PKK).
Nel caso di Kobane possiamo dire che l’opinione pubblica ha influenzato in modo spontaneo Washington allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo una campagna di solidarietà. Come stanno le cose non possiamo sostituire una “forte” copertura mediatica, ma ciò comporta che dobbiamo fare tutto il possibile per assicurare una visibilità alla resistenza popolare siriana: tanto quanto ci dedichiamo alla situazione nel Kurdistan siriano, così dobbiamo assicurarci che la lotta nel resto del paese non venga “dimenticata” mentre continua in condizioni estremamente precarie e la violenza dell’IS oscura quella del regime di Assad.
Esemplarità. La battaglia di Kobane è esemplare ma la resistenza ad Aleppo lo è di meno? La capacità bellica delle forze del PYD si fonda soprattutto sulle sue radici popolari e sulle dinamiche sociali innescate dai provvedimenti rivoluzionari presi nei “tre cantoni” che costituiscono il Rojava (Kurdistan siriano) – ma non abbiamo avuto numerosi esempi di “potere del popolo” anche nella rivolta siriana contro la dittatura di Assad? Il ruolo delle donne nel Rojava e la resistenza di Kobane vengono giustamente accolte ma non è vero che non ci sono state anche nel resto della Siria!
Ci sono vari appelli di solidarietà internazionale con Kobane in cui alcune formule o delle “sviste” mi sembrano abbastanza infelici. Prendiamo ad esempio la giornata di mobilitazione mondiale in solidarietà con Kobane del primo novembre 2014: il titolo avrebbe dovuto menzionare Aleppo e non solo Kobane e non è solo un caso. È stata denunciata la violenza dello Stato Islamico ma non quella del regime di Assad. E poi c’è questa frase: “il modello democratico dell’amministrazione autonoma del Rojava è un esempio per tutte le popolazioni della Siria” che sarebbe accolta con amarezza dalle forze e dai popoli coinvolti in esperimenti democratici altrove in Siria.
La rivolta popolare contro il regime di Assad ha avuto le proprie esperienze sociali, se sono appassite è perché non hanno beneficiato della stessa “finestra” di pace del PYD nel Kurdistan siriano. Sono state immediatamente oggetto della repressione militare da parte del governo e sono state attaccate alle spalle dalle forze sostenute dai regimi che volevano porre fine alla “rivoluzione araba”.
In questo periodo i movimenti popolari nel Kurdistan siriano hanno beneficiato di una situazione di “non guerra” con il regime di Assad (che aveva ritirato le sue forze armate dal grosso del Rojava). Solo di recente hanno subito l’attacco frontale dei movimenti fondamentalisti, in primis, nel maggio 2013, da parte del Fronte al-Nusra e poi, nel settembre 2014, da parte dell’IS. L’attacco è stato feroce, la resistenza degna di nota, le poste erano alte ma la solidarietà internazionale non dovrebbe dimenticare l’importanza del movimento popolare nella rivolta siriana e le tragiche circostanze in cui viene a trovarsi: con tanti nemici mortali e nessun sostegno internazionale degno di nota.
Bombardamenti. Sul confine del Kurdistan iracheno e a Kobane ci sono sono stati dei bombardamenti statunitensi efficaci e senza “danni collaterali” da cui le forze curde sono riuscite a trarre effetti positivi. Non è questo il caso di Aleppo, del campo palestinese di Yarmouk alla periferia di Damasco e così via. Sul piano generale in Siria l’intervento aereo della Coalizione non ha giocato in favore della resistenza popolare: permette al regime di mostrarsi ligio all’accordo e di rivendicare un nuovo riconoscimento internazionale e le sue forze traggono giovamento dal fatto di poter concentrare il loro attacco contro la rivolta popolare. I movimenti fondamentalisti pongono l’accento sulla denuncia dell’intervento imperialista. Assad, come l’IS, attinge ad una nuova legittimazione. Sul piano militare i bombardamenti non allentano la morsa sulle forze progressiste, sul piano politico le riduce.
Qualcuno potrebbe dire che nel caso del Kurdistan iracheno o siriano alcuni bombardamenti statunitensi hanno avuto un valore tattico ma la situazione generale nel teatro delle operazioni mostra che ciò nonostante è disastroso sul piano strategico. Perciò la solidarietà non deve assolutamente schierarsi con l’intervento imperialista, compreso quello in quest’area – ma non deve negare la realtà degli scenari individuali delle operazioni. Deve anche tenere conto delle differenti posizioni dei movimenti che sostiene nel Kurdistan siriano e nel resto del paese. Quest’ultimi hanno esplicitamente condannato l’intervento della Coalizione, i primi hanno pesantemente criticato il non intervento dell’aviazione statunitense a Kobane, poi hanno collaborato attivamente alla sua efficacia quando è iniziato.
La solidarietà non deve schierarsi con il punto di vista di Kobane escludendo quello di Aleppo o viceversa, ma tener conto di entrambi.
Compromesso
Il problema posto dal punto precedente non è capire chi sia più a sinistra (il PKK-PYD o l’FSA?) bensì il rapporto tra la strategia, le tattiche ed il compromesso. Certo, l’analisi di una tattica o di un compromesso dipende in parte dalla percezione che uno ha del/dei movimento/i coinvolti. Quella del PKK-PYD non è ovvia: questi partiti sono sicuramente cambiati ma fino a che punto? Oggi in molti articoli vengono presentati come una corrente libertaria dedita al pluralismo politico, come una sorta di anarco-comunisti armati, per altri mantengono una matrice mao-stalinista che gli impedisce di mettere in pratica il pluralismo a sinistra: un pugno di ferro in un dibattito di velluto. La situazione di guerra e l’urgenza della solidarietà non aiutano a far chiarezza sulla realtà che è probabilmente complessa. In ogni caso la corrente del PKK-PYD è una delle componenti più radicali della regione in termini di progetto sociale e di radicamento nell’estrema sinistra. Probabilmente è la più potente.
Perciò non dovremmo vedere in ogni compromesso l’araldo del tradimento. Molto sintomaticamente il PYD vuole mantenere il controllo delle forze sul campo mentre usa a suo vantaggio il bombardamento statunitense dei veicoli corazzati dell’IS: le organizzazioni curde che ne sono vicine rifiutano sin dall’inizio qualsiasi intervento di terra da parte della Coalizione.
In modo simile nel resto della Siria ci sono stati numerosi accordi tattici e momentanei tra varie componenti armate che si alleavano per combattere il nemico comune del momento ma questa situazione non ha mai indotto le forze della sinistra siriana a mutare il loro giudizio sulla natura controrivoluzionaria dei gruppi fondamentalisti. Qualsiasi compromesso comporta dei pericoli…ma anche il suo continuo rifiuto! È meglio seguire la situazione nel suo divenire piuttosto che precipitarsi a giudicare ogni decisione politica dei movimenti di cui sosteniamo le lotte.
In questo campo il ruolo della solidarietà è di contribuire a creare le migliori condizioni possibili per dei colloqui di pace che permettano la vittoria della lotta di liberazione o della lotta rivoluzionaria. Non stiamo al tavolo delle trattative ed abbiamo come regola generale di non intervenire sulle condizioni dei dibattiti tra i belligeranti, anche se talvolta ci viene chiesto. È il caso del 1973: i negoziati di Parigi avevano portato alla stesura di un accordo che Washington si era rifiutata di concludere. I vietnamiti hanno lanciato un appello all’opinione pubblica e al movimento di solidarietà internazionale per costringere gli Stati Uniti a siglare ciò che poi divennero gli Accordi di Parigi. Noi rispondemmo attivamente a questo appello infrangendo le regole dei negoziati diplomatici segreti.
Gli Accordi di Parigi erano un compromesso che poteva sembrare rischioso ma due anni dopo le truppe statunitensi dovettero letteralmente fuggire dalla catastrofe di Saigon. La crisi che successivamente scosse il “campo socialista” ci ha fatto dimenticare l’importanza dell’evento: la più grande potenza imperialista del mondo aveva condotto in Indocina una guerra controrivoluzionaria totale, su tutti i fronti – una guerra all’epoca ed ancor oggi senza precedenti per le dimensioni dello sforzo bellico, per i mezzi utilizzati e per il suo carattere poliedrico – e l’aveva persa.
Il processo di pace
Se i vietnamiti sono stati in grado di imporre degli “accordi vincenti” nel 1973 è stato grazie alla lotta sul campo, allo sviluppo della solidarietà internazionale e alla grande crisi aperta da questa guerra negli Stati Uniti, ma anche perché avevano imparato le lezioni del 1954 ed avevano tenuto Mosca e Pechino lontani dai tavoli di negoziato.
Lo studio del processo di pace è un aspetto importante di riflessione sulla lotta armata. Possiamo ricorrere ad un gran numero di esperienze in quest’area, storiche ma anche contemporanee. A volte le domande poste sono molto difficili: come si può deporre le armi quando si è circondati dalle armi nemiche? (Questo è il dilemma affrontato dai nostri compagni dell’RPM-M in Mindanao) Come si può, in nome dei diritti di una “minoranza di maggioranza” di una parte di un territorio, non sacrificare i diritti delle “comunità minoritarie” presenti sullo stesso territorio? Per esempio, per tornare al Mindanao, riconoscere i diritti delle popolazioni musulmane senza negare i diritti dei “popoli indigeni” che abitano sulle montagne?
Possiamo negoziare con i talebani in Afghanistan o con l’IS in Medio Oriente senza sacrificare in anticipo i diritti delle donne in nome della “pace”? Quali diritti sociali, ambientali e democratici devono essere salvaguardati per cessare un conflitto militare quando non è nei piani una rivoluzione?
Tutte queste faccende devono essere prese in considerazione dalla solidarietà, altrimenti i “movimenti contro la guerra” o i “movimenti per la pace” possono contribuire a negare i diritti di interi settori della popolazione (donne, popoli indigeni, lavoratori e così via) solo per non complicare un processo di pace già difficile.
Uno dei modi per non tralasciare gli oppressi o gli sfruttati nel corso di un negoziato di pace è di coinvolgerli direttamente nel processo lasciando giudicare loro ogni passo degli accordi proposti: il negoziato dunque smette di essere un incontro faccia a faccia tra le forze armate (governative e d’opposizione) e diventa esso stesso un processo democratico. Questa è l’esperienza dei nostri compagni del Mindanao (sebbene ora gli accordi di pace siano sospesi). La solidarietà può sostenere questa integrazione diretta delle popolazioni nei negoziati da cui dipende il loro futuro.
La solidarietà ieri e oggi
Quindi la solidarietà deve rispondere alle necessità dei popoli e dei movimenti di cui sosteniamo le lotte ma ciò non significa opporre “l’efficacia” ai “principi”. Una gran parte della “sinistra della sinistra” francese si rifiuta di definire il nostro stato come imperialista o non trae nessuna conclusione da ciò (Melenchon ed il PG, il PCF e così via). Altri si sono fatti ingannare facilmente dal discorso sull’”Imperialismo umanitario” della presidenza Hollande quando si stava preparando per l’intervento in Mali oppure si sono confinati in piccole proteste senza alcuna conseguenza. Le correnti politiche (come l’NPA) o le associazioni (come Survie) che stanno provando ad opporsi in modo coerente alla Françafrique si sono trovati in una ristretta minoranza. Di conseguenza non c’è stata la (ri)costruzione di un movimento permanente contro la guerra od antimperialista nonostante il nostro imperialismo intervenga su base permanente in Africa anche e soprattutto sul piano militare.
Una bussola politica è più che mai necessaria per la (ri)costruzione di movimenti duraturi di solidarietà nella misura in cui dobbiamo affrontare situazioni complesse che dobbiamo interpretare con un approccio teorico ma anche con uno sforzo serio per assimilare le realtà sul campo. Quindi è meglio non rifugiarsi nella comodità delle posizioni “di principio” che probabilmente schermano – dietro una semplificazione delle realtà – o conducono a posizioni che a volte sono assurde. Ci è successo negli anni ’60: delle personalità avevano lanciato un appello per raccogliere denaro in sostegno del Governo Rivoluzionario Provvisorio (PRG) nel Vietnam del Sud. Una richiesta semplice, senza alcuna ambiguità e politicamente corretta. Comunque scoprimmo in serata che un solo (!) gollista di sinistra aveva firmato questo appello: orrore! Incarnava “l’ombra” di quella borghesia con cui non poteva esserci alcun compromesso! Cancellammo a penna da ogni manifesto due delle nostre firme (Alain Krivine ed Henri Weber, che all’epoca erano i “giovani”) mentre lasciammo quella di Pierre Frank (il nostro “vecchio”, più ragionevole).
Fortunatamente il ridicolo non uccide altrimenti saremmo morti molto giovani. Se siamo ancora vivi, malgrado qualche attacco di “infantilismo di sinistra”, è anche perché eravamo pienamente coinvolti in tutti le attività reali di solidarietà internazionalista. Abbiamo dedicato molto più tempo all’azione che a darci delle arie.
Non dovremmo enfatizzare troppo l’impegno internazionalista degli anni ’60 in Francia. Infatti il maggio ’68 ha assestato un duro colpo alla solidarietà, con l’estrema sinistra che ha concentrato gli sforzi sulle lotte di classe in Francia: il Comité Vietnam national (CVN, unitario) e i Comités Vietnam de Base (CVB, maoista) cessarono di esistere! Fu necessario ricostruire in modo volontaristico il Front solidarité Indochine (FSI) ciò nonostante per alcuni anni ci fu un dispiegamento di energia e parecchie attività diverse, di massa e a volte clandestine [2].
All’inizio di questo secolo il movimento per la giustizia globale per un po’ ha dato nuova linfa all’internazionalismo dopo un periodo in cui questa aspirazione a volte veniva condannata. La continuità è stata assicurata dai movimenti d’occupazione che si sono succeduti l’un l’altro dall’Egitto ad Hong Kong. Dobbiamo in ogni caso riconoscere che le capacità della solidarietà internazionale rimangono ampiamente inferiori al minimo necessario. Ciò ovviamente riflette l’attuale debolezza delle correnti progressiste radicali nei paesi imperialisti ma anche la perdita di tradizioni ed una difficoltà nel riflettere sulle implicazioni in questo campo dei subbugli geopolitici successivi.
A partire da Bush molti di noi si sono resi conto che stavamo entrando in un mondo di “guerra permanente” senza giungere ad una conclusione che non è mai abbastanza ovvia: dovevamo sostenere “in modo permanente” gli eserciti di resistenza popolare. La crisi di credibilità dell’alternativa socialista è senz’altro così profonda che in svariati conflitti non possiamo dare alcun sostegno ad alcuno dei movimenti coinvolti nella lotta (Afghanistan, Pakistan, Libia e così via, dove potremmo anche sostenere movimenti non armati), ma ci sono dei casi in cui possiamo (Siria, Kurdistan e così via).
Più in generale di fronte agli abusi commessi da bande armate di tutti i tipi si presenta il tema dell’autodifesa delle organizzazioni o delle comunità la cui esistenza è minacciata, anche se la risposta a queste minacce deve essere soprattutto politica quando la stessa “lotta armata” non è in agenda.
In alcuni casi (probabilmente rari) dobbiamo rispondere ad appelli urgenti per chiedere che i nostri governi forniscano armi. L’esempio di Kobane dimostra che i detti governi possono essere obbligati a farlo. L’esempio di Aleppo ha confermato che non vogliono. Nel contesto siriano questa è sicuramente una richiesta antimperialista.
Questo articolo è centrato sulla solidarietà con la resistenza armata, comunque “l’aggiornamento” dei compiti della solidarietà emerge in tutti i campi. Ciò è vero ad esempio per la risposta ai disastri umanitari, tra cui quelli climatici, o per la capacità dei movimenti sindacali di coordinarsi meglio nel sostenere le lotte sul lavoro in un’epoca di catene di produzione globalizzate.
Non possiamo immaginare le nostre responsabilità internazionaliste senza un coinvolgimento più ampio e sistematico delle organizzazioni politiche e sociali progressiste – e senza un sostegno finanziario più consistente alla resistenza. Senza mezzi e logistica la politica sarà impotente.
Note
[1] Nelle aree tribali del Pakistan c’è una combinazione degli sviluppi internazionali – il “jihad”, l’intervento statunitense e così via – con quelli nazionali – le rivalità tra le fazioni dell’esercito – e quelli locali – le mutevoli alleanze tra i capi delle tribù e dei clan.
[2] Sto parlando dell’Algeria, del paese basco sotto Franco e dei disertori statunitensi della Guerra del Vietnam
da internationalviewpoint.org
Traduz. Emanuele Calitri