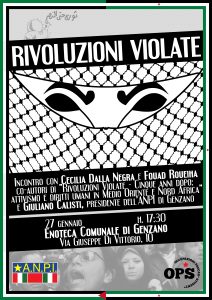di Marco Bertorello e Danilo Corradi (Communia Network)
Quello che è accaduto in Grecia costituisce un giro di boa nella nostra storia. Come spesso accade in un breve lasso di tempo si chiariscono cose ferme da molto. Il doppio passaggio referendum-accordo avvenuto nell’arco di una settimana deve essere letto insieme. Da un lato la volontà popolare a dire No (Oxi) all’Europa, nonostante le fortissime pressioni e, soprattutto, le lunghissime code ai bancomat, e dall’altro un accordo che in sostanza risulta peggiore di quello respinto con il referendum stesso. Un accordo che ha un valore economico e dunque drammaticamente materiale, ma anche, e forse soprattutto, un valore politico.
L’austerity è fallita, viva l’austerity!
L’accordo è sostanzialmente caratterizzato dalle ormai storiche richieste della Troika, a partire da quelle che dovranno essere approvate a stretto giro per ottenere i primi prestiti ponte: riforma delle pensioni, aumento dell’Iva, dare operatività al Fiscal compact, adozione delle norme europee che vietano aiuti pubblici al sistema creditizio, e poi in tempi di poco più lunghi, riforma del mercato del lavoro (leggasi licenziamenti più facili, svuotamento dei contratti collettivi). Fin qui, dunque, niente di nuovo, sono i soliti meccanismi che sono all’opera, fallimento dopo fallimento, da prima dello scoppio della crisi. Con una differenza di gradi, considerando il punto di partenza, la drammaticità delle condizioni sociali greche e la situazione generale in cui si trova il paese ellenico.
Ma non basta. Ciò che rende ancora più insopportabile l’accordo sono i tempi e le garanzie richieste. Per iniziare a fornire parte degli 82 miliardi di euro previsti, le principali riforme andranno approvate in pochi giorni e contemporaneamente il governo greco dovrà costituire un fondo per le privatizzazioni per un valore di circa 50 miliardi. I finanziamenti verranno elargiti dietro la garanzia dei gioielli di famiglia che ancora restano alla Grecia. Una esautorazione completa di sovranità che si aggiunge all’ininfluenza della consultazione referendaria. Dunque la Troika si rafforza disponendo addirittura di un dispositivo in più nella governance europea. Con questo accordo, dunque, la Grecia si trova un cappio al collo che verrà stretto (blocco dei finanziamenti) ogni qual volta le controriforme non verranno attuate (privatizzazioni di porti, aeroporti, luoghi in grado di produrre profitti…).
Il male si trasforma in soluzione?
Tutta l’operazione viene presentata all’interno del solito vestito ideologico: l’austerità produrrà avanzi di bilancio per ridurre il peso dell’indebitamento, le privatizzazioni e l’eliminazione dei diritti attrarrà i capitali e gli investimenti che a loro volta consentiranno una ripresa economica attraverso la crescita. Insomma il solito farmaco, in dosi sempre più massicce somministrato a un malato che si aggrava di giorno in giorno. Non si capisce perché qualche miliardo in più investito nella crescita questa volta dovrebbe dare risultati che finora non sono arrivati. Curioso che anche Tsipras questa volta intenda afferrare l’occasione. Come se da ora anche il governo pensasse che attraverso «un accordo recessivo» (parole del premier greco) si potesse invertire la rotta. Il male si trasforma improvvisamente nella soluzione?
Non affrontare il macigno del debito, chiaramente insostenibile, significa pensare che anche un’eventuale diluizione del suo pagamento (che il governo ellenico considera possibile, ma di cui non a caso non vi è traccia nel testo dell’accordo) andrebbe inquadrato nella logica della crescita economica. Il contesto resterà quello di prima, nessun provvedimento di rottura o di rimessa in discussione delle logiche di austerità, ma se la Grecia farà i suoi compiti a casa il debito potrà diventare un poco più sopportabile. Il perno è la crescita capitalista, il mercato l’unica soluzione possibile. Inizialmente nelle trattative sembrava che la contropartita per le controriforme fosse una parziale ristrutturazione del debito, ora invece appare chiaro come si siano invertiti i termini della questione: grazie alle controriforme si potrà ottenere la riduzione del debito, forse.
Il re è nudo
Il blocco centro-europeo dopo il referendum ha voluto stravincere, e nessuna parvenza di alternativa è emersa dagli altri paesi periferici o dalla Francia. Anzi l’indirizzo di quest’ultimi è stato unicamente quello di essere più timorosi nell’eventualità della Grexit, poiché poteva rappresentare una battuta d’arresto della loro modesta ripresina. La Germania e i paesi del suo blocco economico più omogeneo, non hanno temuto la rottura con il piccolo paese ellenico, anzi. A un certo punto della trattativa è emersa chiaramente la volontà di proporre solo due possibilità a Tsipras: rottura o umiliazione? La ragione era più politica che economica. Permettere anche una parzialissima, piccolissima vittoria del governo greco avrebbe significato, dopo il referendum, una possibile estensione della crisi politica dell’Europa. Questa eventualità spaventava la Troika molto di più di un nuovo scossone finanziario di cui nessuno poteva prevedere le reali conseguenze.
Le stesse forze socialdemocratiche non hanno svolto alcun ruolo al di fuori di questo schema, anzi l’isteria pre-referendum di alcuni leader socialdemocratici la dice lunga sui ruoli svolti. Dopo l’ennesimo accordo capestro c’è chi parla di ripartenza dell’Europa, di recupero di identità, ma in realtà la partita del cambiamento è già stata giocata. Il resto è ipocrisia.
La chiusura dell’eurozona definisce un giro di boa, la sua irriformabilità chiude degli spazi. Si tratta di prenderne atto.
Il piano B: meglio un salto nel vuoto che uno nel nulla
La mancanza di un piano B ha indebolito la trattativa e ha determinato il fallimento della linea di Tsipras. La scelta del referendum appare incomprensibile considerato l’esito della presunta trattativa. Il governo greco ha ipotizzato di utilizzare il risultato del referendum come elemento di pressione, sottovalutando gli interessi in campo. Per certi versi Tsipras l’ha fatta grossa, ha promosso la partecipazione popolare per poi inibirla immediatamente dopo. Ora in Grecia come in Italia, è tempo di ipotizzare rotture, anche della moneta unica se necessario, perché solo degli strappi unilaterali possono determinare dei cambiamenti. Le possibili ricostruzioni e alleanze sociali nel futuro prossimo non potranno che essere scomposte, affatto lineari, di rottura del quadro dominante attraverso strappi. L’uscita dall’euro però nonostante diventi un’opzione politicamente più ragionevole, non risolve i problemi che hanno origine su scala globale. Bisogna comunque continuare a tessere una tela sovranazionale, per quanto incompleta e piena di contraddizioni, sugli obiettivi di fondo capaci di invertire i rapporti di forza, a partire dal debito. Da questo punto di vista banalizzare le difficoltà di un piano B è politicamente superficiale e indebolisce un’alternativa. Non è utile negare che una rottura avrebbe implicato una crisi di liquidità, un regime di incertezza diffusa, un indebolimento immediato della Grecia nel quadro internazionale. La stessa sponda Russa non costituiva una valida alternativa, non sarebbe stata offerta senza pesanti contropartite. Non è su uno scacchiere geopolitico o monetario che si risolvono i problemi della contemporaneità per le classi subalterne. Tutti fattori che non possono essere sottovalutati. Inoltre va sottolineato che la solidarietà europea è stata molto al di sotto delle necessità e delle possibilità. Troppo facile dare consigli ai greci senza mettersi in gioco. Ma nonostante tutto ciò, come ha detto in questi giorni un dirigente greco la sinistra deve persino provare a fare dei salti nel vuoto piuttosto che nel nulla.
L’accordo reggerà?
La domanda è d’obbligo. Tsipras troverà una nuova maggioranza? Cosa succederà quando l’accordo si trasformerà in provvedimenti? È già stato indetto uno sciopero generale del pubblico impiego e speriamo che sia solo l’inizio. Dall’altra parte le contraddizioni non sono minori. L’Inghilterra ha già annunciato che non metterà un euro per il salvataggio della Grecia, il fondo salva stati sembra dunque inutilizzabile, mentre l’accordo dovrà essere ratificato da diversi parlamenti e tradotto in dispositivi concreti. Il partito degli scettici sembra particolarmente agguerrito. Il caso greco è tutt’altro che concluso. Riusciranno i movimenti sociali europei a divenire il fattore imprevisto di questa vicenda epocale? È la sfida impellente che abbiamo di fronte.